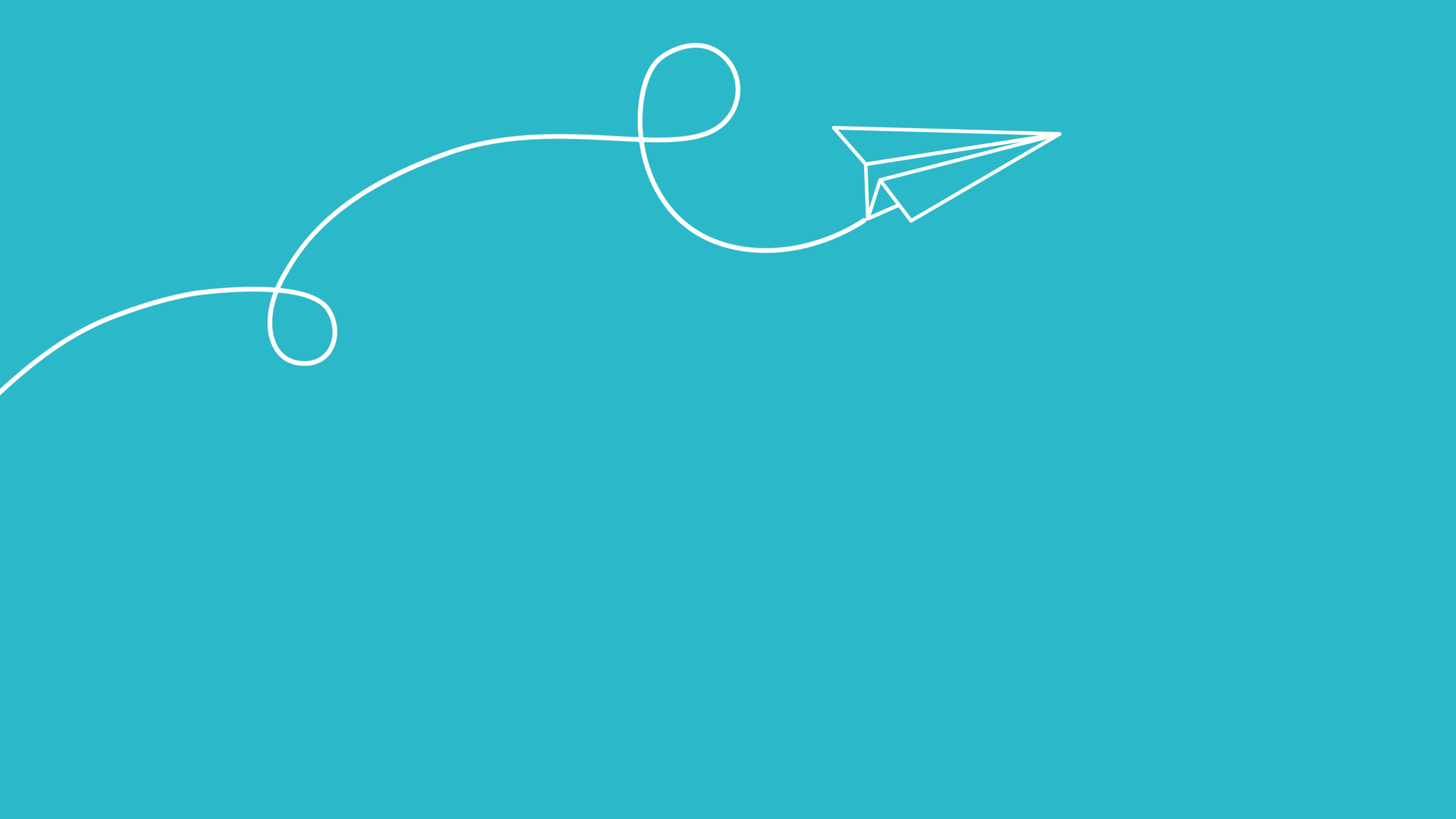Che lavoro fa uno psicologo? Di cosa si occupa uno psicoterapeuta e come opera? Perché rivolgersi a una figura professionale come questa?
Ne ho parlato durante un incontro di network con professionisti ed imprenditori che svolgono lavori anche molto diversi dal mio, per provare a uscire da alcuni preconcetti legati a questa professione e per spiegare di che cosa essa tratti, come la svolgo e perché.
Sentire l’altro come parte di sé
Proviamo a pensare a un attore: chi recita deve essere capace di vestire i panni altrui, di entrare nella parte, di sentire quel personaggio molto vicino a sé, addirittura a volte di diventare quel personaggio per un periodo di tempo.
Ebbene, qualcosa di simile lo fa anche lo psicoterapeuta: egli infatti deve sentire l’Altro, il paziente, come una parte di sé per poterlo comprendere, metterlo un po’ dentro di sé.
Quando ho una persona davanti a me in seduta, il mio compito non è valutarla, bensì sentirla, ascoltarla, guardarla: non osservo, ad esempio, come questa sta seduta per giudicare se è a disagio o meno, per coglierla in fallo se fa un gesto di chiusura, ma per capire come si sta sentendo in quel momento.
L’analista che analizza per giudicare è un mito da sfatare! Perché si tratta esattamente del contrario.
Se una coppia di genitori arriva in studio per loro figlio e la mamma ha le braccia incrociate e lo sguardo puntato su di me, questi sono due segnali di comunicazione non verbale di cui devo tenere conto, ma non per dire che la signora ha un atteggiamento di chiusura. Il suo atteggiamento e i suoi gesti mi raccontano che questa mamma è a disagio, o preoccupata o diffidente: e come la si può biasimare? È lì per affidare a me, che in quel momento sono una perfetta sconosciuta, la cosa più importante della sua vita: suo figlio.
Fare ordine, fino a trasformare

Proviamo a pensare a un cuoco: le interpretazioni, in seduta, assomigliano ai piatti di un ristorante. L’analista prende alcuni elementi indigesti del paziente che assomigliano a dei cibi crudi, un mix di ingredienti, e insieme a lui li cucina, li elabora, li trasforma in piatti fumanti e digeribili.
Si può essere uno chef pluristellato e preparare un arrosto strepitoso, ma se il cliente aveva chiesto un piatto di tagliolini, l’arrosto non verrà apprezzato né, soprattutto, capito. Perché non era ciò che era pronto a mangiare in quel momento. Così, allo stesso modo, l’abilità dell’analista non sta nel cucinare al posto del paziente proponendogli un piatto pronto e già cucinato, ma, insieme a lui, trasformare quei cibi crudi e un po’ indigesti in qualcosa di buono, digeribile e gustoso. E replicabile. Dove? Nella vita di tutti i giorni, fuori dai 50 minuti una volta alla settimana.
Proviamo a pensare a ciò che fanno le mamme coi loro bambini appena nati: un neonato non lo sa che cosa siano tutte quelle sensazioni corporee che prova e che all’inizio sono spaventose per lui. Sarà la mamma inizialmente, e poi il papà, a dare un nome alle cose che sente, rispondendo a un bisogno: questa è fame e ti allatto, questo è sonno e ti ninno fino ad addormentarti, questa è cacca e andiamo a cambiarci il pannolino.
Si dà un nome alle cose che si sentono

Questo è ciò che faccio in seduta.
Perché a volte una persona che approda in studio non sa esattamente cosa sta provando e cosa gli sta capitando: spesso i racconti dei pazienti, all’inizio, sono un elenco di accadimenti, fatti, persone incontrate, di “cosa ho detto” e di “cosa ho fatto”.
Ma se a quella persona chiedo: “Come si è sentito in quella situazione? Che cosa ha provato?” spesso ci si imbatte nel vuoto. Manca una risposta.
A un uomo di circa 30 anni che parlava ininterrottamente e facevo fatica a stargli dietro, a un certo punto gli chiesi come si sentiva in quel momento lì.
Ascoltata la domanda, dopo un attimo di disorientamento, riprese a parlare di quello che pensava. Lo fermai di nuovo: “provi a sentire cosa sente e prova, non a che cosa sta pensando.” Lui mi guardò, sperso: “Sa che non lo so?” “Bene – gli risposi – Adesso possiamo cominciare”.
Imparare a raccontarsi a partire dall’ascolto di sé

I racconti dei pazienti si trasformano nell’arco della terapia perché diventano memorabili. Si arricchiscono di colore, il paziente impara a raccontarsi a partire dall’ascolto di sé.
Che cosa mi piace? Chi voglio diventare? Che cosa è giusto per me?
Chi ha visto “Se scappi ti sposo” sa che Maggie Carpenter, interpretata da Julia Roberts, sceglieva come mangiare le uova in base a come piacevano al fidanzato del momento.
Il mio compito come psicologa non è dire ai miei pazienti se le uova sono buone strapazzate o alla coque. Ciò che chiedo loro è: come ti piacciono le uova? E se non lo sai, proviamo insieme ad assaggiarle e poi deciderai il modo giusto PER TE.
La psicoterapia è come una storia

Proviamo a pensare alla psicoterapia come a un viaggio, come a una storia. Chi è il protagonista?
Non è lo psicologo, l’eroe è il paziente.
Il paziente che approda in studio da me spesso è come un Dante.
Dante non lo fa da solo il viaggio: c’è Virgilio ad accompagnarlo nel profondo degli Inferi.
E c’è uno Yoda che in Star Wars dice a Luke Sky Walker che la forza sia con te. In terapia aiuto i miei pazienti a cercare la forza che è dentro di loro e a tirarla fuori.
I pazienti in un percorso di analisi trovano dentro di loro le risorse per affrontare il loro viaggio che è la vita: perché la terapia non è il raggiungimento del Nirvana o della pace dei sensi. La vita continuerà sempre a metterci di fronte delle difficoltà o degli ostacoli. La terapia è ciò che aiuta ad avere gli strumenti adatti ad affrontarli. E anche a superarli.
Tanti pazienti che arrivano in studio hanno cercato così tanto di difendersi dai loro dolori da sembrare dentro a quelle armature medievali, che sì, riparano dai colpi e dalle frecce, ma quanto è faticoso starci dentro e quanta poca libertà di movimento si prova a stare in quegli affari?
Michelangelo Buonarroti diceva che nella scultura bisogna procedere per via di levare: dal masso di marmo, dotati di scalpello, si toglie tutto ciò che non serve, che è di troppo e che appesantisce, per tirare fuori la figura umana, la sua essenza e armonicità.
Il mio ruolo in terapia
Che il mio ruolo sia YODA, Virgilio o Michelangelo poco importa.
Questo è quello che faccio tutti i giorni nel mio studio: aiutare i miei pazienti a cercare la forza, la via che è già dentro di loro e a tirarla fuori e a trovare la via per uscire dalla selva oscura, senza bisogno di chiudersi dentro a gabbie per proteggersi.
E a quel punto il mio lavoro è finito ed è ora che io mi congedi.
Perché il paziente ha interiorizzato, cioè ha messo dentro di sé ciò che abbiamo fatto in seduta: il modo di ascoltare, ascoltarsi, raccontare, raccontarsi.
Ha sviluppato dentro di sé la funzione che gli permette di elaborare ciò che accade, nel suo mondo interno ed esterno; e quella funzione la può portare con sé nel mondo e nella sua vita di tutti i giorni .
Ed è allora che il mio paziente ed io prendiamo congedo l’uno dall’altra: ed io lo guardo proseguire per la sua strada con un po’ di commozione ed un pizzico di orgoglio.